
Poi, un giorno, con calma cercherò di capire meglio perché mi accade questo.
Ogni volta.
Perché quando provo ad andare a visitare al Centro 22 luglio, dove sono già stata, mi perdo. Perdo l’orientamento. In pieno centro città.

Nel senso che so dove si trova questo Centro, ma non riesco a trovarlo. Nemmeno con Google Maps.
Vago per ore, gli giro intorno, ma non riesco a raggiungerlo. Poi, al secondo o al terzo tentativo, talvolta il giorno dopo, va tutto bene.
E mi dico: “Ma come ho fatto a non svoltare subito qui? È un attimo, a pensarci bene!” – mentre mi avvicino alla porta di ingresso.
Ho bisogno di perdermi, almeno una volta? O forse una parte di me non vuole davvero entrare lì?
(non c’è da scomodare uno psicanalista, per capire il perché)

Ho un legame forte con questo centro di documentazione. Un legame mio, certo, legato anche al lavoro che faccio nella vita di tutti i giorni.
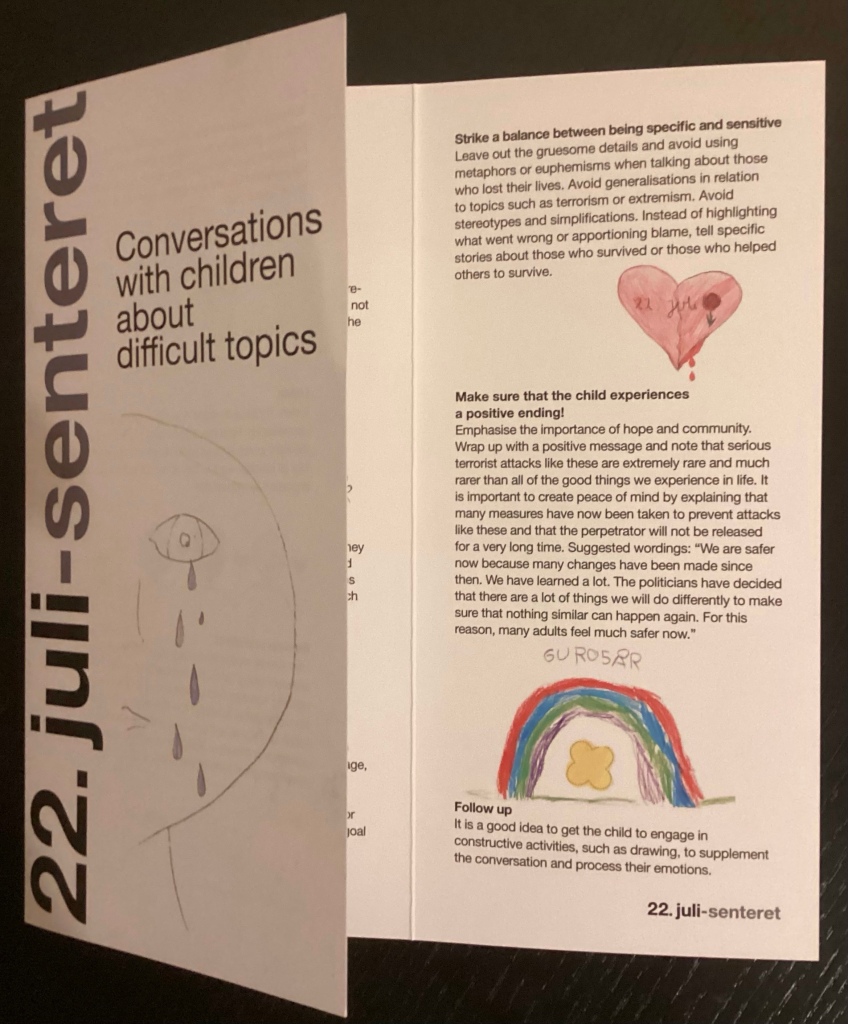
Si tratta di un luogo in cui è stato raccolto molto del materiale legato a quello che è accaduto – tra Oslo e l’isola di Utøya – il 22 luglio del 2011, quando Anders Behring Breivik, un estremista di destra, nello spazio di poche ore ha ucciso 77 persone, lavoratori che si trovavano negli uffici di un palazzo del Governo e decine di adolescenti, che si divertivano partecipando ad un campeggio-studio organizzato dal Partito Laburista sull’isola di Utøya.
Ogni volta che varco la soglia di questo Centro, mi torna in mente una testimonianza letta anni fa su un réportage, uscito ad un anno esatto dai fatti, nel 2012.
Una testimonianza che non potrò mai dimenticare, al di là di quelle, spesso piene di orrore, che ho letto e visto negli anni che ci separano da quella data.
Una ragazza quel pomeriggio ha visto morire la sua migliore amica, che si trovava sul pontile dell’isola di Utøya, poco dopo che Breivik, travestito da poliziotto, era sbarcato dal traghetto che lo aveva portato lì.
Un colpo di pistola alla tempia l’aveva uccisa, insieme ai due adulti che si trovavano con lei e che stavano cercando di capire cosa volesse da loro quello strano poliziotto.
Breivik l’aveva uccisa, proprio mentre chiedeva gridando: “Ma cosa stai facendo? Perché lo fai?”
La ragazza che aveva assistito a tutto questo, stando poco lontano, si era salvata nascondendosi, ma, nei mesi successivi, aveva continuato a mandare ogni sera un sms all’amica – come era stata sua abitudine fino al giorno della strage.
Era convinta che, prima o poi, avrebbe ricevuto una risposta. Questo aveva detto al giornalista che l’aveva intervistata.
Si potrà parlare di una forma di stress post-traumatico, oppure si potrà parlare di Filo d’Oro, quello che, secondo Jung, unisce, al di là dello spazio e del tempo, due persone che si sono individuate in qualche modo, tra tante altre.
A voi la scelta.
(io ho scelto la seconda)
Secondo me, l’amica ha ricevuto tutti quei messaggi e, di certo, avrà trovato il modo di inviare qualche segnale a chi l’aveva amata così tanto.

Con questa storia ben chiara nella mente, dopo aver finalmente trovato la sede del Centro, la mattina della domenica ho fatto il mio ingresso.
In punta di piedi. Come avevo già fatto in precedenza.
C’erano dei cambiamenti, rispetto all’anno prima.
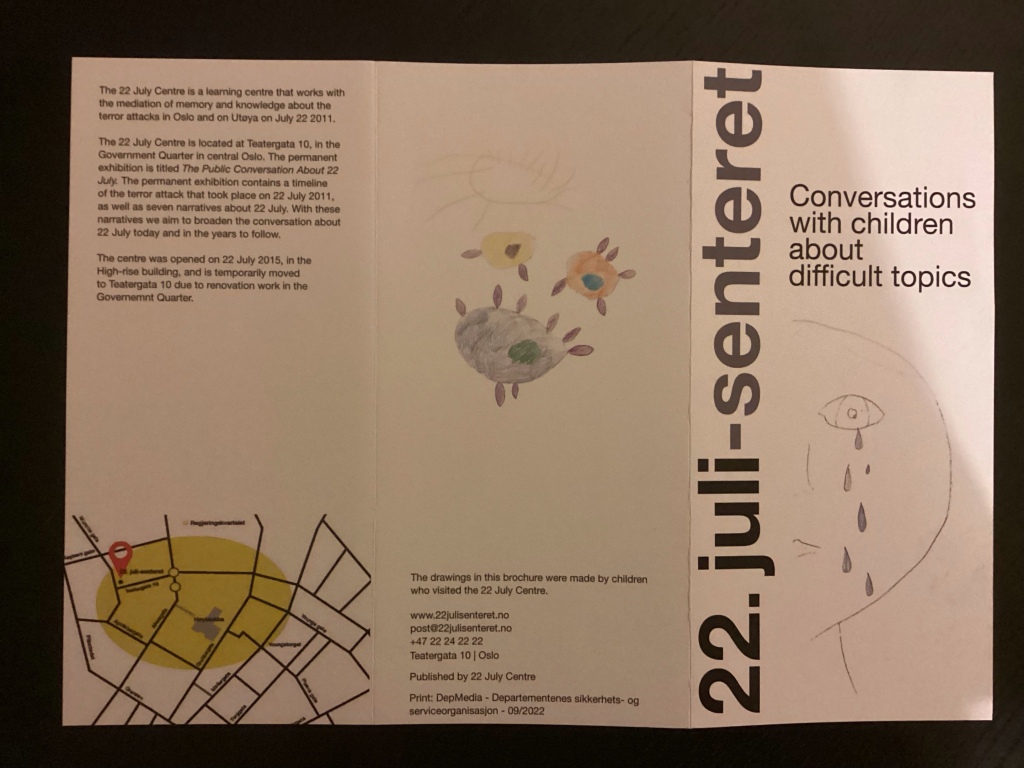
Nella grande sala che si trova all’inizio, era stata allestita una mostra con le prime pagine dei giornali di tutto il mondo, uscite il giorno dopo la strage.

Al centro della sala campeggiava un orologio – di cui ho già parlato – quello che si trovava nella piazza su cui si affacciavano gli uffici governativi dove è esploso il furgone bomba che ha ucciso otto persone.
Un orologio a cui manca un grosso frammento, distrutto dalla deflagrazione.
Una metafora evidente di ciò che è accaduto quel giorno, quando la serenità di fondo di un intero popolo è stata messa così duramente alla prova.
Tutto il resto è rimasto immutato.
I pannelli con la cronologia dei fatti.

(Breivik aveva studiato e cronometrato tutto, fin nei minimi particolari: dall’abbigliamento, alla scelta delle armi, alla preparazione dell’esplosivo, che aveva iniziato a mettere insieme mesi prima)

La sala con i racconti dei parenti delle vittime. Quella con le testimonianze dei sopravvissuti.

Ancora una volta mi sono seduta su una delle panche ed ho visto scorrere le immagini. Ho ascoltato storie già sentite, fino ad arrivare a quella che volevo ascoltare.
Di nuovo.
La ragazza che quel giorno si era trovata nella sala conferenze. L’unica sopravvissuta, in un ambiente in quel momento gremito di ragazzi come lei.
Breivik è entrato lì e, con molta calma, ha annunciato che li avrebbe eliminati, uno ad uno.
E così ha fatto.
Il tutto è avvenuto in un’atmosfera surreale, quasi silenziosa, quella di chi non può credere che le cose stiano andando proprio in quel senso.
Il silenzio di chi sa che morirà, senza alcun dubbio, senza poter fare nulla.
Ho ascoltato di nuovo il racconto pacato di quella giovane ragazza.
La voce calma e priva di pathos, quella di chi sta ancora combattendo con il senso di colpa di essere ancora lì, a raccontarla a noi.
È lei – a parte Breivik – l’unica testimone di quei momenti. È lei, che conclude il suo racconto, stando seduta nel punto esatto della sala in cui si trovava in quei momenti, alzando una mano. Solo alla fine.
È lì che cade il velo.
La ragazza ha fatto quel gesto e ora so che è comune a quasi tutte le vittime, ai sopravvissuti in situazioni simili.

Anche Viljar Hanssen – ferito anche lui gravemente in quella strage – ha una identica ferita: anche a lui mancano le ultime dita di una mano.
Perché – anche se ti sparano con un cannone – la prima cosa che fai è alzare la mano, metterla tra te e chi ti vuole uccidere, per proteggerti.
Sai bene che è una specie di follia, ma è una follia istintiva. Meccanica. Automatica.
Ci provi. Comunque. Anche se sai che quello sarà quasi di sicuro il tuo ultimo gesto.
Anche quel ragazzo che si vede in quell’assurdo fotogramma della ripresa dall’elicottero della polizia stava facendo quell’identico gesto.
Si vede benissimo, anche nel fotogramma sgranato.
Era immerso a metà nell’acqua, si era accorto che Breivik stava prendendo la mira contro di lui ed aveva alzato la mano, per ripararsi.
Per difendersi.
Ancora una volta, anche quest’anno, terminata la mia visita, sono uscita.
In silenzio.
Meditando su questa storia e come poterne mantenere viva la memoria.
Anche nel mio lavoro.

L’anno prossimo voglio fare visita ad Utøya. Voglio andare a vedere di persona. Non per turismo macabro, ma perché quando devo capire bene una cosa, devo anche vederla bene. Essere nei luoghi di cui intendo parlare nelle cose che scrivo.
Riguardo all’isola, mi ha colpito un particolare, drammatico e poetico nello stesso tempo.
Questo luogo, colpito in modo così pesante da una violenza insensata, sta tornando ad essere quello che era fin dall’inizio: un posto in cui si coltivano pensieri di pace.

I ragazzi sono tornati ad animarla. Perché è giusto così. La vita deve riprendere la sua strada e dare un senso nuovo alle cose.

C’è un punto dell’isola in cui è stato realizzato un memoriale, sul quale sono incisi i nomi di tutte le vittime. Sono incisi sul metallo. Su queste incisioni, nel giorno del compleanno di ognuno, vengono messi dei fiori colorati. La gentilezza dei fiori è un richiamo più forte della tristezza che trapela ancora da quel bosco, da quello spiazzo su si trovava il campeggio, dalla sala conferenze.
Dei fiori.
Per dare un senso. Per non dimenticare.
(e noi non dimentichiamo)


